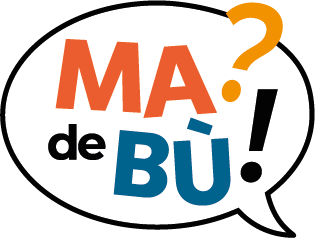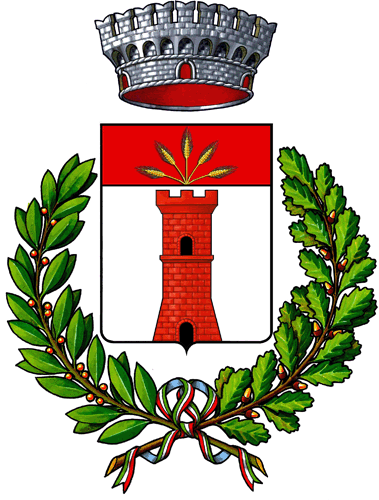Le Anverarde
Nel corso del 1900, lungo via Roma erano presenti cinque osterie, luogo d’incontro e di ristoro per la comunità e per chi era di passaggio.
Uno di questi era l’Osteria del Cavallino, detta anche delle Anverarde.
L’osteria nacque nel 1800 e i primi proprietari furono Giuseppe Galleri e sua moglie Caterina. Si dedicavano soprattutto alla vendita del vino sfuso, tanto che il locale era chiamato fiaschetteria. Sarà il figlio Celeste con la moglie Angela Bottana ad ampliare i servizi di ristoro.
Angela apriva i battenti ancor prima dell’alba, alle tre del mattino, per accogliere i lavoratori. Di lì passavano i menalat che raccoglievano il latte, i postiglioni che recuperavano la posta al crocevia, i careter ovvero i carrettieri che avevano la possibilità di far riposare i loro animali nella stalla in fondo al cortile. Questi ultimi, dopo aver consumato le deliziose pietanze che offriva la locanda, ne approfittavano per coricarsi sulle gimbarde, una specie di amaca che serviva per il trasporto del fieno.
In seguito alla scomparsa del marito, Angela fu aiutata dalle figlie Ninì, Caterina e Bice, Edvige.
Il menù dell’Osteria del Cavallino era vario:
Verdura – cotta, cruda o sotto forma di giardiniera, direttamente dall’orto in fondo al cortile.
Carne – lessa e cotta sulle stufe. Accanto all’orto c’erano infatti il pollaio e la conigliera, mentre per la carne di mucca o di maiale ci si riforniva dalle cascine del paese.
Trippa – il piatto forte
Pesciolino Fritto – pescato da Martino Gualé nei fossi, in cambio del vitto.
Vino, prodotto dall’osteria con l’uva dei filari di Capriano del Colle, vendemmiati e pigiati grazie all’aiuto degli abitanti del paese che volevano assicurarsi il diritto di consumare gratuitamente un po’ di vino una volta imbottigliato.
Tra i personaggi che frequentavano l’osteria c’era ache un trafficante che vendeva galète, patuna, macagne, mondoil cioè arachidi, castagnaccio, mele cotognate, marroni.
Le locandiere non erano disturbate da questa vendita, perché il sale e la disidratazione degli alimenti faceva vendere più vino.
C’era anche il fotografo Carnaghi, che metteva in posa fino allo sfinimento i clienti prima di scattare. Vi erano poi musicisti improvvisati e cantanti dalle doti nascoste, apprezzate solo dal ristretto pubblico che affollava il locale.
L’osteria delle Anverarde era anche un luogo di comunità e di raccolta per il poco tempo libero della comunità.
Sui tavoli di legno rimane ancora il solco dei gomiti, ricordo delle lunghe partite di briscola. Nel cortile si giocava con le bocce in cemento, grazie anche al fratello Giovanni che si curò di creare il bocciodromo. Spesso d’estate il portico si trasformava nel teatrino dei giupì, dei burattini, attirando grandi e piccini.